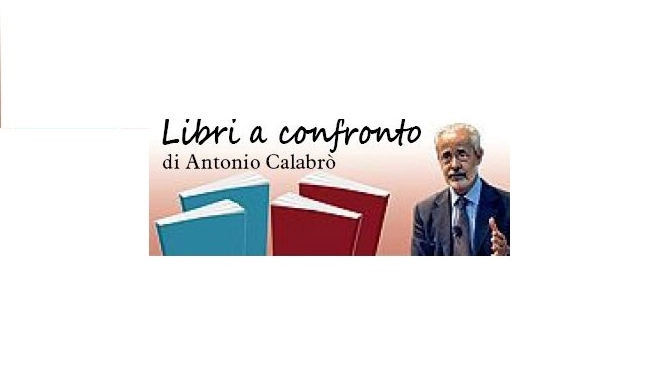
Libri a confronto di Antonio Calabrò
Milano, 20 novembre 2016 - STORIA e cronache del nostro paese. Da originali punti di vista. Quello del cinema, per esempio, nelle pagine di Alberto Crespi, “Storia d’Italia in 15 film”, Laterza. Si comincia dal Risorgimento con le immagini di “1860” di Blasetti per continuare, tra l’altro, con “La grande guerra” di Monicelli, il fascismo nel racconto di “Amarcord” di Fellini, la disfatta dell’8 settembre 1943 con “Tutti a casa” di Comencini, il dopoguerra con “C’eravamo tanto amati” di Scola, il boom economico con “Il sorpasso” di Risi, la stagione degli anni di piombo con “Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto” di Petri e così via continuando, sino a oggi, con “Gomorra – La serie” di Sollima. Punti di vista, ben motivati, mentre ogni film rimanda ad altri film, piccoli e grandi capolavori.
La Storia si rivela attraverso storie. E mostra sempre tratti di contemporaneità. Lo sguardo può concentrarsi su un momento simbolico. Come fa, per Longanesi, Alfio Caruso in “1960 - Il migliore anno della nostra vita”: si parte con l’Oscar delle valute dato dal “Financial Times” alla nostra lira e si continua con fatti e dati che descrivono un Paese che cresce, lavora, consuma. Ecco la Tv (i successi de “Il Musichiere” e l’ottimismo della sigla, “Domenica è sempre domenica…”) e i grandi film, come “La dolce vita” di Fellini. La morte d’un campione, Fausto Coppi. Le novità di Mina e Celentano. Le Olimpiadi di Roma. L’emigrazione. Le tensioni contro il governo Tambroni, incline a destra e sconfitto da trame democristiane e proteste popolari. E le speranze legate a due figure carismatiche: papa Giovanni in Vaticano, John Kennedy alla Casa Bianca. Sicurezze d’un avvenire migliore. Anni felici, appunto. Anche se poi…
E gli anni infelici? Potrebbero essere quelli attuali, in aree in cui declina la tradizione industriale e null’altro prende il suo posto. Come racconta Angelo Ferracuti in “Addio”, per Chiarelettere. È “il romanzo della fine del lavoro”, un romanzo-verità (come “Il costo della vita” e “Andare, camminare, lavorare”) ambientato in Sardegna, area del Sulcis-Inglesiente, terra di miniere oramai improduttive e di fabbriche, l’Alcoa, che chiudono perché la proprietà multinazionale trova più conveniente produrre alluminio altrove.
Le lotte operaie, la vita grama di migliaia di famiglie, le speranze d’assistenza della “mano pubblica”. E il tramonto di una civiltà il cui il lavoro era reddito, ma soprattutto identità e dignità, pur con un’acuta contraddizione tra salute (compromessa, da anni in miniera) e salario. L’epica industriale resta memoria, in pagine intense e dolenti. L’attualità è quella d’una provincia tra le più povere d’Europa.
Ma c’è anche un diverso punto di vista, da cui leggere l’Italia. Positivo. Mettendosi in sintonia con l’evoluzione del mondo delle imprese. Come in “Lettere dal futuro”, a cura di Gianfilippo Cuneo per Egea, con una presentazione di Elena Zambon, leader dell’omonimo gruppo farmaceutico e presidente dell’Aidaf (l’associazione delle imprese familiari): “Generazioni di imprenditori si raccontano”. Sono 25 “lettere” scritte al fondatore dell’azienda, con l’ambizione di continuare a interpretare, innovando, lo spirito dei tempi. Firme note: Bonfiglioli, Ceretto, Fumagalli Romario, Garrone, Lavazza, Lunelli, Zoppas e altri ancora. Nelle pagine, il ritratto del “quarto capitalismo” delle “multinazionali tascabili”, con una nuova “governance”: strategie e responsabilità di fondo agli azionisti, gestione ai manager capaci, anche esterni alla famiglia. Un percorso difficile. Ma virtuoso.

